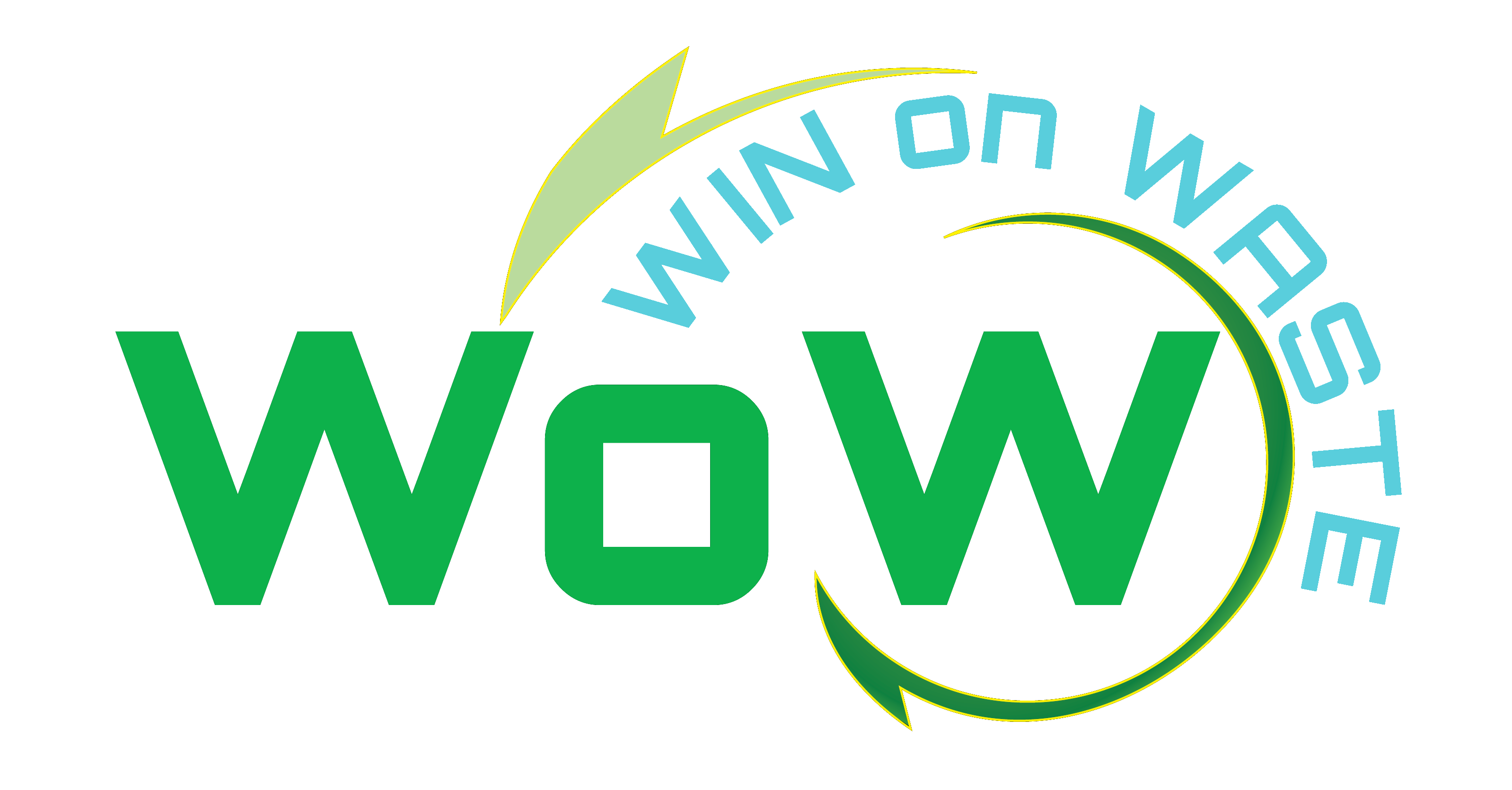La mattina, dopo pranzo, durante una pausa: il consumo di caffè è un rito quotidiano, un momento di piacere e socialità che unisce il mondo intero. Non è un caso, infatti, che, con una stima di tre miliardi di tazzine consumate ogni giorno a livello globale, questa bevanda sia la più popolare al mondo. Il 1° ottobre, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè, istituita nel 2015 dall’Organizzazione Internazionale del Caffè (ICO) per celebrare l’intera filiera, dai coltivatori ai baristi, è il momento ideale per guardare oltre l’aroma e la crema. Qual è il costo nascosto dietro questo rito? E, soprattutto, come possiamo ridurne l’impatto ambientale?
La filiera tradizionale del caffè, infatti, è un esempio emblematico di economia lineare. Dalla piantagione alla tazzina, il percorso è lungo e dispendioso in termini di risorse. La coltivazione intensiva, spesso in monocolture, in molti casi richiede ingenti quantità d’acqua e l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici che impoveriscono il suolo, col rischio di contaminare le falde acquifere e senza contare il triste contributo alla deforestazione e alla perdita di biodiversità. A questo si aggiunge l’impronta di carbonio legata al trasporto dei chicchi per migliaia di chilometri e al processo di tostatura.
Tuttavia l’impatto più evidente, e forse paradossalmente la più grande opportunità, risiede negli scarti: l’industria globale del caffè genera circa 40 milioni di tonnellate di rifiuti di biomassa ogni anno. Questi non sono solo costituiti dai fondi che restano nella moka o nella macchina del bar, ma anche dalla polpa e dalla mucillagine del frutto del caffè, scartate durante la lavorazione, e dalla pula (o silverskin), una sottile pellicola che si stacca dal chicco durante la tostatura. In un modello lineare, tutto questo materiale finisce in discarica, generando costi di smaltimento ed emissioni di metano. Nell’ottica dell’economia circolare, invece, questi “rifiuti” diventano materie prime seconde, pronte a inaugurare nuovi cicli produttivi.
Da scarto a risorsa: la seconda vita dei resti del caffè
La trasformazione degli scarti del caffè è un campo in piena effervescenza, dove ricerca e innovazione stanno aprendo scenari sorprendenti. Le possibilità di valorizzazione sono numerose e toccano settori molto diversi tra loro.
Energia dal caffè: biocarburanti e pellet
I fondi di caffè possiedono un alto potenziale energetico. Una delle applicazioni più dirette è la loro trasformazione in pellet per stufe e caldaie, un biocombustibile che offre un’alternativa più sostenibile ai combustibili fossili. La ricerca, però, si è spinta oltre: a Londra, ad esempio, alcuni dei celebri autobus a due piani sono alimentati da un biodiesel (B20) che contiene un 20% di bio-componente derivato dall’olio estratto dai fondi di caffè raccolti in città. Ogni tonnellata di fondi può produrre circa 200 litri di biocarburante. Altri studi stanno esplorando l’uso degli scarti del caffè per “nutrire” microalghe destinate alla produzione di biodiesel, creando un doppio beneficio: smaltire un rifiuto e generare energia pulita.
Nuovi materiali per bioedilizia e design
I fondi di caffè si stanno rivelando un componente prezioso per la creazione di nuovi materiali sostenibili. Incorporati in polimeri riciclati o bio-based, danno vita a composti termoplastici utilizzati per stampare oggetti di design, complementi d’arredo e molto altro. Startup italiane come Coffeefrom stanno trasformando tonnellate di fondi esausti dell’industria alimentare in granuli pronti ad una nuova vita. Nel campo della bioedilizia, la ricerca sta sperimentando l’uso dei fondi di caffè carbonizzati (attraverso un processo di pirolisi) come aggregato per produrre un calcestruzzo più resistente e leggero che consente, al contempo, di ridurre l’estrazione di sabbia, una risorsa naturale sempre più sotto pressione.
Leggi anche: Macchina da caffè con capsule. È davvero il regalo migliore?
Dalla cosmesi all’agricoltura: un valore a 360 gradi
Le applicazioni circolari non si fermano qui. La silverskin, la pellicola del chicco, contiene grassi e antiossidanti che, una volta estratti, possono essere utilizzati dall’industria cosmetica per produrre rossetti o creme anti-age. I fondi di caffè sono già noti come ottimi esfolianti naturali per la pelle.
Uno degli utilizzi più virtuosi è, però, il ritorno alla terra: i fondi sono un eccellente fertilizzante per l’orto e il giardino, ricco di azoto, potassio e magnesio e possono essere usati anche come substrato per coltivare funghi commestibili, come i Pleurotus, trasformando lo scarto di un bar in cibo a chilometro zero. Tale approccio crea un sistema a circuito chiuso, riducendo i rifiuti e generando nuovi prodotti commercializzabili.
Oltre il riciclo: l’agricoltura rigenerativa per guarire il suolo
Se la gestione degli scarti chiude il cerchio a valle, l’economia circolare applicata al caffè richiede un ripensamento anche a monte, a partire da come viene coltivato. Qui entra in gioco l’agricoltura rigenerativa, un approccio che va oltre la semplice sostenibilità e mira a ripristinare attivamente la salute degli ecosistemi agricoli. Invece di limitarsi a ridurre l’impatto, l’obiettivo è lasciare il suolo in condizioni migliori di come lo si è trovato.
Nel caso del caffè, questo si traduce principalmente in pratiche di agroforestazione ovverosia la coltivazione delle piante di caffè all’ombra di alberi nativi più alti. Questo sistema può apportare molteplici benefici. Vediamone insieme alcuni.
Arricchimento del suolo: le foglie che cadono dagli alberi creano uno strato di pacciamatura naturale che decompone, fertilizza il terreno e ne aumenta la capacità di trattenere l’acqua, riducendo la necessità di irrigazione e di fertilizzanti chimici;
Tutela della biodiversità: la copertura arborea ricrea un habitat per uccelli, insetti e altri animali che, a loro volta, contribuiscono al controllo naturale dei parassiti;
Resilienza climatica: un sistema agroforestale è più robusto e resiliente agli eventi climatici estremi, come siccità o piogge torrenziali;
Qualità e reddito: spesso, le piante di caffè che crescono all’ombra producono chicchi di qualità superiore. Inoltre, gli agricoltori possono diversificare il loro reddito coltivando anche la frutta o il legname degli alberi della copertura.
Diverse aziende stanno già investendo in progetti di caffè proveniente da agricoltura rigenerativa certificata, dimostrando che un modello produttivo che rigenera le risorse naturali non è un’utopia, ma una realtà praticabile e vantaggiosa.
Leggi anche: Agricoltura rigenerativa e impatto sociale. L’esempio di Nzatu e delle produzioni di caffè solidali
Un aroma di cambiamento: il ruolo di ognuno di noi
Come emerge, la transizione verso una filiera del caffè completamente circolare e rigenerativa è un processo complesso che richiede l’impegno di tutti gli attori. Le aziende hanno la responsabilità di investire in ricerca, ridisegnare le filiere e supportare i coltivatori che adottano pratiche a minor impatto. I governi e le organizzazioni internazionali, come l’ICO, hanno il compito di creare un quadro normativo che incentivi questo cambiamento e garantisca un giusto reddito ai produttori che, spesso, rappresentano l’anello più debole della catena.
Tuttavia, anche i consumatori hanno un potere enorme: scegliere caffè proveniente da commercio equo e solidale o corredato da certificazioni ambientali (come Bio, Rainforest Alliance, Regenagri®) significa inviare un segnale forte al mercato (attuando il famoso principio del votare con il portafoglio). A casa, possiamo fare la nostra parte non gettando i fondi di caffè nell’indifferenziato, ma usandoli per le piante o nel compost.
La Giornata Internazionale del Caffè ci ricorda, quindi, che ogni tazzina che beviamo ha una storia. Sta a noi scegliere di sostenere una storia di rigenerazione, innovazione e rispetto per il pianeta, trasformando uno dei piaceri più diffusi al mondo in un piccolo, ma potente, motore di cambiamento.
Leggi anche: Come riciclare i fondi e gli scarti del caffè: 4 soluzioni ecosostenibili che forse non conoscete
© Riproduzione riservata
L’articolo Come ridurre l’impatto del caffè che beviamo ogni giorno proviene da EconomiaCircolare.com.